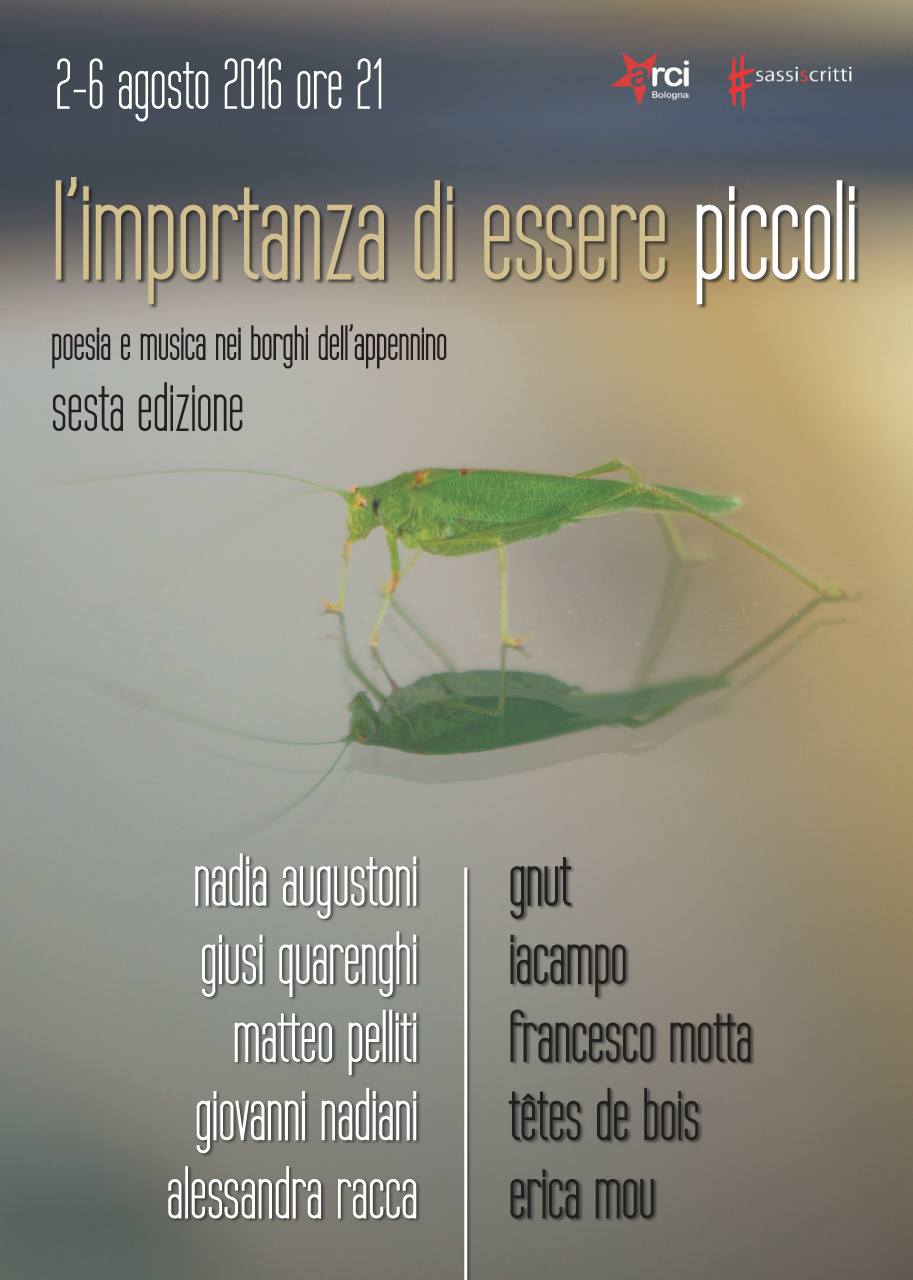sabato 30 luglio 2016
venerdì 29 luglio 2016
Universitaly, Federico Bertoni, edizioni Laterza 2016. Da "Alfabeta 2" che ringraziamo

L’università sotto assedio
Pubblicato il · in alfapiù, libri · 4 Commenti
 Daniele Balicco
Daniele Balicco
Universitaly
di Federico Bertoni è un saggio politico. Il suo oggetto immediato è la
metamorfosi inquietante dell’università pubblica in Italia; ma, come in
ogni vero esercizio saggistico, l’oggetto è in realtà pretesto per un
discorso più generale. Bertoni, mentre discute di università e di
ricerca, sta in realtà costringendo il lettore a riflettere su una
questione di fondo, inaggirabile benché ovunque elusa: se si manomettono
le forme istituzionali di educazione pubblica di massa è la qualità
stessa della nostra democrazia a essere a rischio. Questo è il nodo
attorno a cui il saggio ruota. E il decalogo che chiude il volume – le
dieci pratiche di resistenza a cui il testo invita – andrebbe letto come
un piccolo manifesto portatile di disobbedienza civile. Ma andiamo con
ordine.
Universitaly
si apre con una domanda spiazzante: «perché un luogo di elaborazione e
di trasmissione della conoscenza diventa uno straordinario concentrato
di stupidità, in cui l’automazione frenetica delle pratiche svuota di
significato le azioni quotidiane?». La risposta non è semplice e il
testo prova ad articolarla in tre mosse. La prima si intitola esperienza. Federico Bertoni è professore di letterature comparate e teoria della letteratura all’Università di Bologna. È dunque un insider.
Per spiegare come si insegna e come si fa ricerca oggi, il primo passo è
quello di descrivere in presa diretta la vita quotidiana di un
professore italiano. Bertoni si diverte a mostrare la follia della routine
nella quale è imprigionato; ma il tono generale della scrittura è
amaro. In questa prima parte del volume lo seguiamo mentre cerca di
dribblare il sovraccarico di burocrazia, la mole di email senza fine, le
richieste sempre più astruse degli organi di valutazione della ricerca,
gli intimidatori comandi dei centri informatici, la scrittura a ritmo
fordista di abstract,
le lettere di presentazione per gli studenti, eccetera… Ma il lavoro
del professore universitario non dovrebbe essere quello di fare ricerca e
di insegnare? Sembrerebbe di no. È stato costruito, in meno di due
decenni, un esorbitante apparato normativo che per funzionare richiede
un lavoro continuo. Ed è precisamente questo il lavoro per cui viene selezionato oggi un professore universitario. Ricerca e docenza passano in secondo piano.
La seconda mossa del saggio si intitola narrazione e ha il compito mostrare al lettore i dispositivi che producono il discorso sull’università,
vale a dire quella rappresentazione aggressivamente demolitoria del
sistema pubblico alla quale da oltre due decenni siamo quotidianamente
sottoposti. A iniziare dalle classifiche di rating
mondiali: tutti sappiamo che il nostro sistema non eccelle in queste
classifiche. Pochi però si interrogano sul senso di una comparazione che
valuta realtà quasi incomparabili. È sensato analizzare allo stesso
modo una piccola università privata come Harvard, che ha poco più di
15.000 studenti e che da sola ha un finanziamento pari al 40%
dell’intero sistema pubblico italiano, con una università statale come,
per esempio, quella di Bologna, dove gli studenti sono quasi 100.000 e
le risorse finanziarie, rapportate alle sue dimensioni, sono decisamente
scarse? E come mai, nonostante questa disastrosa posizione,
l’emigrazione scientifica italiana ha assunto ovunque posizione di
rilievo proprio perché molto ben preparata? Non è forse che i conti non
tornano del tutto?
Il discorso sull’università
ipnotizza però la discussione pubblica soprattutto con tre concetti:
merito, eccellenza e valutazione. Sono tre termini tossici. Perché
impediscono di ragionare seriamente sul significato politico di
un’istruzione universitaria di massa. Bertoni giustamente ricorda che
«la meritocrazia tende a premiare chi può accedere a grandi risorse,
opportunità, orizzonti sociali e culturali, reti di relazioni. Non c’è
bisogno di essere raccomandati dal potente di turno per essere favoriti
nella competizione: basta nascere in una “buona” famiglia, crescere in
un ambiente sereno, avere i mezzi per viaggiare o studiare le lingue,
disporre di una grande biblioteca, rientrare in un sistema ramificato di
scambi e di relazioni sociali». Ed è per questa ragione che «merito è solo un altro nome per privilegio». Il secondo termine tossico è eccellenza.
Presentata come obiettivo da conquistare grazie al merito, l’eccellenza
non è altro che una martellante strategia retorica. Si vuole
compensare, in realtà, il senso profondo del fallimento istituzionale
dello Stato, nascondendo cause e responsabilità politiche. L’ultimo
concetto ipnotico è quello di valutazione:
il dispositivo che deve certificare l’eccellenza. Queste sono, fra le
pagine del libro, quelle più importanti, un vero e proprio microsaggio
di retorica, di politica e di psicologia sociale. Bertoni interpreta la
valutazione come un dispositivo di potere che impone, in chi lo subisce,
una sorta di auto-coercizione volontaria con effetti pratici immediati:
è dal buon funzionamento di questo dispositivo, infatti, che dipendono
fondi di ricerca, acquisizioni e posti di lavoro.
L’ultima mossa del volume prende il nome di politica. Bertoni avanza un’analisi impietosa di come l’università si sia progressivamente trasformata in una consumer oriented corporation
senza alcuna forma di opposizione da parte di un corpo docente per lo
più irresponsabile perché incapace di difendere il nesso humboldtiano
ricerca-educazione, ripensandolo all’altezza del presente. A questo
quadro già di per sé sconfortante si aggiunga poi una dosa massiccia di
esterofilia, aggravata, nel caso della ricerca umanistica, da un senso
di inferiorità verso le scienze pure e il loro delirio di onnipotenza.
Come se ne esce? Il libro si chiude con dieci azioni semplici e due
libri. Anzitutto dieci piccole pratiche di resistenza quotidiana capaci
di mantenere viva un’idea altra di università come istituzione in grado
di «promuovere una buona qualità media dell’istruzione collettiva, di
fondare il progresso del Paese nell’estensione dei diritti e delle
opportunità sociali». Quindi la lezione di due libri di Luigi
Meneghello: I piccoli maestri (1964) e Fiori italiani
(1976). Entrambi insegnano cosa produce l’uso sbagliato dei libri: uno
scollamento sempre più grave fra conoscenza astratta ed esperienza del
mondo. Quanto una buona università dovrebbe con ogni forza scongiurare.
A
margine, una riflessione. È possibile pensare la trasformazione attuale
dell’università come risposta politica a un problema di fondo, che
potremmo identificare nel nesso fra qualità dell’istruzione di massa e
conflitto sociale potenziale? Uno studio degli archivi della Fulbright
Commission, sugli anni Settanta italiani, potrebbe forse rivelare
risposte inaspettate. In questi anni ci siamo tutti dimenticati che
l’istruzione pubblica resta uno dei campi privilegiati della battaglia
per l’egemonia.
Federico Bertoni
giovedì 28 luglio 2016
I consigli di Lucio, Libreria Utopia
| ||||||||||||||
martedì 26 luglio 2016
Danilo Montaldi, Edizioni Colibri
Inoltre, mi rendo perfettamente conto di quanto sia insufficiente una critica che si eserciti quasi unicamente nei riguardi della linea politica dell’organizzazione. Infatti, quando anche venisse dimostrato che "la linea" è tutta fondata su erronee interpretazioni della realtà italiana e internazionale (e, di questo fatto, non sono pochi i militanti del PCI, dall’alto in basso, che ne sono convinti, ma secondo loro è un problema di strategia non incrinare, in modo alcuno, l’organizzazione), rimarrebbe pur sempre il problema di capire perché e come mai il proletariato italiano ha considerato, pur tra strappi e pause, il PCI come il proprio partito rappresentativo di massa, lungo i decenni di un’incessata battaglia. È che le organizzazioni politiche hanno uno spessore, una corposità e una dimensione più vasti di quanto esprima semplicemente "la linea", la quale è uno soltanto – anche se, alla fine, determinante per il suo sviluppo a lunga scadenza – degli elementi di vita dell’organizzazione.
Nell’analisi della formazione di determinate tendenze negative nella condotta del Partito comunista in Italia, mi sono guardato dal ricorrere, sia pure involontariamente, alle facilità della retrodatazione: prima di tutto, tale modo di procedere è stato troppo usato dalla storiografia ufficiale del PCI, sia per valorizzare l’opera di determinati dirigenti sia per screditare definitivamente quella di altri, perché si possa, semplicemente e in termini capovolti, utilizzarla, oggi, nei riguardi di uomini e di particolari situazioni di movimento, contro lo stesso PCI ; poi, è un metodo che ridurrebbe ad astratta razionalità un’opera vasta, fitta, difficilmente interpretabile se si tiene conto che essa è tuttavia in relazione con la classe nuova nella storia, con il proletariato, i cui momenti organizzativi, di reazione, di coscienza e di volontà, non sono facilmente accostabili nell’uso di criteri volgarmente ammessi. Sappiamo, per esperienza, che la lotta di classe è asprezza, dissonanza; inutile cercare di ottenere, dal bronzo della storia, logiche armonie che ci soddisfino razionalmente. Nel libro, viene spesso ripercorsa la traccia delle opposizioni interne ed esterne al PCI in quanto esse costituiscono un insieme di elementi che vanno intesi in un divenire; esse consentono infatti di capire il dopo, che ha avvio dal periodo ’68-69, che stiamo vivendo.
Così si parte, nel presente saggio, da punti, molto spesso, assai lontani, per arrivare sempre, e di continuo, al presente, a questa chiara e difficile situazione, sovrastata, per quanto concerne il PCI, da una politica negativa in quanto chiusa alle possibilità cui aspira la classe operaia da quando essa ha coscienza di sé. E qui entrerebbero in causa le difficili relazioni che sono state di gruppi dirigenti dei partiti operai, in Italia, con la teoria rivoluzionaria, con il marxismo.
Dove, nel saggio, ed è tutta una prima parte di lavoro, si discute, dal passato al presente, delle caratteristiche teorizzazioni di Togliatti, si vuole anche vedere chiaramente di che si componga l’insistente interpretazione della società italiana, condotta con un metodo che sta tra lo storicistico e il positivistico, sancita da un gruppo dirigente che ha segnato di un orientamento complesso, ma tutt’altro che marxista, il divenire dell’azione comunista nel Paese. Secondo me, non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di eliminare dalla coscienza collettiva comunista l’ipoteca posta su di essa dall’indottrinamento d’origine e derivazione staliniana e togliattiana. Frequenti saranno dunque i richiami a Bordiga, a Gramsci; ma il problema non consiste in una partigianeria di cognomi, di tendenza. E, di questo, penso ci si possa rendere conto alla lettura delle pagine che seguono, che vogliono dare materiali per una storia tuttora inconclusa. Anche per questo, ogni paragrafo tende a essere il principio e il termine del saggio.
Problema essenziale di questo lavoro è di contribuire, insomma, alla lotta in corso contro un potere disumano, nel rinnovato assalto che, dopo anni di attese tattiche, si muove alla ricerca di una visione di strategia.
Al di là della polemica contro istituti retrivi, affermati o in divenire, se dalle pagine che seguono appare, in qualche modo, l’indicazione di un utile orientamento di pensiero e di azione, esse possono pretendere al diritto di non essere state scritte invano.»
dalla “Premessa” di Danilo Montaldi
http://www.colibriedizioni.it/
lunedì 25 luglio 2016
Omnibus & filosofia
Dal fatto di prender posto in un omnibus, anche a degli intervalli
più o meno lunghi, l'uomo che sa viaggiare può trarvi le più diverse
lezioni (e le più alte) di saggezza, di eguaglianza, e delle più
squisite virtù. L'autobus è alla volta un mezzo di trasporto ed un
ammirevole strumento di bella e sana morale.
I. L'attesa, l'eguaglianza e l'obbedienza alle leggi
Siamo a Lione... Un gruppo compatto di esseri di tutte le
condizioni, di tutti i costumi e di tutte le età, aspetta sull'orlo del
marciapiede d'un quai del Rodano, in un luogo esposto alla pioggia, al sole, alla fanghiglia, l'arrivo del tram o dell'autobus desiderato.
Il quarto d'ora del generale nippone Nogi! Saper tenere, sapere attendere!...
Che bella lezione ha avuto così la popolazione lionese durante tutto il tempo del «grande macello» leggendario!
Per distinguersi gli uni dagli altri, questa gente che aspetta deve
avere e tenere in mano un pezzetto di carta. Questi pezzetti di carta
sono numerati da 1 all'infinito in ticket staccati da un
apparecchio speciale. La macchina, qui, come altrove, rimpiazza l'uomo
(ahimé! Dove andremo a finire con queste macchine!...).
Sia essa giovane, bella, bisbetica, adorabile, indesiderabile,
vecchia, grassa, magra, sfiancata, la donna aspetta; impiegato, operaio,
commendatore, ladro, spia, aviatore, truffaldino, prete, bagarino,
lenone, capo di ufficio e per conseguenza decorato, amato, ingannato,
l'uomo aspetta.
Quindi? Eguaglianza dei sessi, soppressione dell'ineguaglianza di
condizioni. Soppressione anche dell'ineguaglianza delle attitudini; e
là, sta il fatto più rimarchevole.
Riformato definitivo, inadatto temporario, servizio armato o
servizio ausiliario o civile, qualunque sia il vostro valore
professionale, qualunque siano i vostri diplomi, le gite a domicilio
coatto, gli inviti a Corte, la vostra superiorità intellettuale, la
vostra esperienza della vita, l'ingegnosità negli scrocchi e truffe
giornalieri, l'onestà, il candore, le imbecillagini che avete fatto e
che sperate di fare ancora, le vostre condanne, le vostre relazioni
politiche; voi passerete nel tram, quando chiameremo il numero impresso
sul vostro ticket. Non avanti!
— Collaborazione della folla e dell'elite, diciamo noi —
forza del numero o del numero debole, rispetto delle leggi e, quantunque
sia molto bene di giammai confessare, potete ben farlo nel dirci che
non v'è spettacolo più riconfortante, più nobile e più economico come
quello ci presenta la moltitudine nell'attesa di un tram.
II. L'arrivo o la lotta del bene e del male — L'Indulgenza
Ma, delle volte, l'ineguaglianza dei caratteri si manifesta, ahimé!
irresistibilmente e più presto del tempo che metterebbe un deputato
socialista a dire una menzogna nei suoi discorsi in Parlamento.
È all'arrivo dell'autobus che quelli che non sanno attendere, gli
impazienti, gli irosi, gli invidiosi, le donnette che abbiamo fatto bene
di non sposare o prendere per amanti, le persone equivoche, i nuovi
poveri, i nuovi ricchi, tutta la poltiglia scatenata da questi lunghi
anni di mattatoio smascherano in poche riflessioni la loro bruttezza
morale.
Questo spettacolo, visto dalla piattaforma dell'autobus dove siete
installato da qualche tempo, vi dà un piccolo riassunto della struggle for life di Darwin, o la lotta per un posto di deputato o di spazzaturaio al Parlamento.
In piccolo sotto i vostri occhi e sotto le suole delle vostre
scarpe, sta tutta la vita sociale riunita in questo gruppo da 15 a 200
persone che si stringono, si schiacciano, si insultano onde far
prevalere il loro «numero», delle volte prima degli altri, contro
l'evidenza del numero stesso.
Qui si combattono le passioni lillipuziane, minuscole, immagini delle grandi, mastodontiche passioni della vita.
Orgoglio, vanità, entusiasmo, odio, altruismo, interesse, tutto è
lotta in basso, sul marciapiede, sul predellino, nella pioggia, nella
neve, nel fango. Voi, sul tram, siete l'uomo «arrivato», che ha il suo
posto e la sua sicurezza nella società, come un capitalista qualunque.
Che piova o che tiri vento, voi siete al coperto, voi avete l'anima
serena ed indulgente come il papa; voi giudicate meschini i sentimenti
di quelli che cercano di arrabattarsi per giungere sino a voi e che sono
nella folla, nella polvere, nel fango, in basso del tram. Voi giudicate
utopico il desiderio di questa gente che cerca di montare sul tram,
come il desiderio di un arruffone che mira a adagiarsi nella società
borghese e danarosa, dove gli impieghi, anche infami, sono sicuri e
rimunerativi.
Questo padre di famiglia con i suoi due marmocchi sulle braccia e
sua moglie accanto a lui che ne ha altri due sono letteralmente
schiacciati dalla folla dei pretendenti al tram. Essi lottano contro il
soffocamento, come lo si fa in grande con la vita. E, siccome sono sei, e
non scenderanno mai più di tre o quattro persone alla volta, essi non
monteranno giammai insieme. Questo esempio vi ricorda il problema del
Malthusianismo e la bellezza di crearsi una numerosa prole nella
«Società Corda e Sapone». Se qualche onorevole deputato vorrà
interessarsi del problema della popolazione e spopolazione, approfitti
dell'esempio di cui sopra; lo studio è facile e... rimunerativo.
— Un solo posto in prima classe!
Rauca, armoniosa, deliziosa, imperativa o seducente, la voce che
s'incanala nel vostro orecchio, disillusiona, scoraggia e disorienta gli
umili, i pezzenti, i bombardati dalla miseria. Essi, i poveri paria,
non monteranno in quel carrozzone che il buon De Amicis ci descrisse sì
bene; essi aspetteranno, forse non partiranno mai, se ci sono soltanto
dei posti in prima classe. La vita è cara! Avreste il coraggio di
pagarvi un lusso eguale in questi tempi di restrizioni? Un solo posto in
prima classe: come c'è un solo posto di direttore nella Banca d'Italia:
— Un posto solo in seconda classe!
— Monta, Geltrude, andrò a piedi.
— No, Clodomiro, vai tu: aspetterò l'altro tram.
Qui, la mia attenzione si porta sulla solidità delle virtù
coniugali. E a parte queste virtù, non vi sembra di vedere i due
candidati dello stesso collegio che, ispirati dal Governo e da qualche
biglietto da mille, si cedono il posto a vicenda? (Pel bene della
«patria», s'intende!)
Intanto nel tram il posto vuoto è preso da quegli che è solo,
sparigliato, vedovo, celibe o prete. Infamia! è l'egoismo che trionfa,
che arriva prima degli altri come un neo-consigliere municipale o
segretario di una confederazione del lavoro qualsiasi.
Come le spese occulte ed accessorie di palazzo Braschi, ecco l'uomo
che ha tramato nell'ombra... Egli monta sul tram quando questo riprende
il suo percorso, grazie ad una tenue mancia elargita di nascosto.
Arrivista! va, corri, tu abusi del triste potere del denaro come un
volgare ministro!
La signora che ha il numero 606 ha potuto montare sull'autobus
perché il giovincello del numero 527 le ha ceduto il posto. Essa si
installa. In questo momento arriva l'uomo dal numero 523 e dovrebbe
occupare appunto il posto della signora 606. Egli non insiste. È il
perfetto rappresentante dei timidi, di quella categoria che non osa e
che non arriverà mai a farsi una prebenda come il vescovo di Napoli.
Fissate questo timido: vi accorgerete subito che esso non è nato per
truffare, per arrabattarsi, per arrivare, per giocherellare il levati tu che mi ci metto io! come tutta quella gentaglia di cui è inutile intrattenerci.
III. Lezione di rassegnazione e di speranza — Conclusione
Il tram è partito. Non bisogna credere che i buoni se ne vanno e
che i cattivi restano. L'uomo che ha il numero 790 sussurra al suo
vicino: «Io non invidio quelli che sono partiti; partire, è morire a
metà». Ma quelli che sono partiti sono pieni di speranza! Però, come le
persone già al posto, essi hanno le loro ineguaglianze ed i loro incubi.
Il loro posto è instabile come un impiego losco; essi sono soggetti
agli urti, alle spinte, alle schegge di vetri fracassati che sono gli
scandali. I più esposti agli accidenti, che comporta il tram o la vita,
sono delle volte quelli che pagano più avanti, più vicino alla luce od
al motore. Un ladro che ha scorto una spia, trae dalla tasca un giornale
cattolico, lo spiega in tutti i sensi che si può immaginare, ci si
nasconde e legge senza leggere...
— Piazza del Cimitero! La corsa è finita.
Sic itur ad astra. Ed è qui, come nella vita, che bisogna
rinunciare alle migliori cose, ai più belli e deliziosi miraggi, agli
impieghi più sicuri, prendere la pensione (se ne avete diritto), finir
sempre o, se non siete arrivato all'ora finale, rimettervi a vivere od a
vegetare quando non ci pensavate più, o partire per delle nuove strade o
verso degli scopi, che non sono nuovi...
Folgorite [Sante Ferrini]
Saggi di storia contemporanea, Stamperia libertaria, Parigi, 1923
venerdì 22 luglio 2016
Claudia Zonghetti e Anna Karenina
Dire quasi la stessa cosa: Claudia Zonghetti e Anna Karenina
Io e Anna
(e che Woody Allen e Lev Tolstoj mi perdonino)
Ci ho messo più di un mese a rispedire il
contratto di traduzione per Anna Karenina. Anzi, in realtà non l’ho
nemmeno fatto io. Ad affrancarlo e imbucarlo è stata un’amica, dopo
settimane che cercavo di dimenticarmelo nella borsa mentre il fantasma
di Leone Ginzburg infestava i miei sogni (questa dei sogni sarà una
costante, mettetevi comodi).
Insomma sì. Anna Karenina. IL romanzo. Quello che TUTTI
dicono di avere letto e amato. (Sapeste, però, in quanti mi hanno
confessato di “aspettare la mia traduzione per leggerlo, finalmente”,
annaffiando la mia ansia e confermando l’urgenza di una “questura
letteraria” che sgonfi le cifre dei lettori presunti…)
Sto tergiversando, lo so.
Ma come si fa a spiegare cosa sono stati, per me, i mesi fra i due treni di Anna Arkad’evna?
Proverò a mettere insieme qualche pensiero.
Prima di tutto: NO, non avevo sempre
accanto la traduzione di Ginzburg. Né altre traduzioni esistenti. Che
possiedo, in numero di nove, fra italiano, francese, spagnolo, inglese,
tedesco. Le ho guardate poco e niente. Non per supponenza, ma per
problemi di orecchio. Il mio è una carta moschicida, un camaleonte
piuttosto arzillo, dunque il rischio che poi seguissi accordi altrui era
alto. Mentre io volevo tenermi il più possibile al russo – e ai russi –
di Tolstoj. È forse per questa ragione che ho usato per la prima volta
anche un audiolibro.
In fondo il nòcciolo è proprio questo,
credo. Il “lurido vecchio” (mi ripeto, lo so, ma ho amato ancora di più
Anna Achmatova scoprendo che lo apostrofava a quel modo) ha saputo dare a
ognuno dei suoi personaggi una voce riconoscibile. Ognuno di loro ha i
suoi tic lessicali o sintattici, ognuno – o quasi – ha un suo lessico famigliare
(eccoli, marito e moglie riuniti), le sue idiosincrasie, i suoi vezzi.
Il tentativo è stato, dunque, quello di provare a restituire a ognuno
una veste altrettanto riconoscibile nel corso delle – tante – pagine.
Ho avuto anche io i miei “preferiti”. Il
principe Ščerbackij, per esempio, uomo di ironica saggezza con la
battuta sempre in resta: uno spasso unico e – credo – colui che mi ha
permesso di giocare di più con la lingua (cercatevi i barlacci e
sappiatemi dire che cosa ne pensate). O la principessa Mjagkaja,
brontolona enfant terrible che per prima osa dire ad alta voce
quanto ridicolo e insulso sia Karenin. Così come ho avuto giornate in
cui, all’ennesima fienagione, mandavo mail deliranti al mio redattore
chiedendogli il permesso di cambiare il finale e di spingere sotto il
treno qualcun altro. Non sono mancati – confesso – nemmeno bizzarri
accostamenti cinematografici che, tanto per citare il più imbarazzante,
mi hanno aiutato a rendere noiosamente e vezzosamente pignolo Karenin
(se qualcuno volesse cimentarsi, azzardi pure un nome e dirò se ha fatto
centro). Il tutto mentre la notte ricevevo le visite non troppo
frequenti, ma comunque assidue, di due soli personaggi: Karenin
(intenzionato a dimostrarmi d’essere più simpatico di quanto io
credessi) e Oblonskij (all’inesorabile ricerca di prestiti). Non ho mai
sognato lei, Anna Arkad’evna.
Forse perché l’ho ingenuamente – e
banalmente – adorata. In ogni sua piega emotiva e lessicale, di nuovo.
Perché anche lei cambia drasticamente modo di esprimersi fra il prima e
il dopo-Vronskij. Passando dalla sintassi compunta (ma mai leziosa) e
ben impostata della perfetta dama dell’alta società alle frasette
nervose, isteriche, sincopate e a volte insulse delle liti ormai quasi
folli con Vronskij.
Il contorno è stato una continua
scoperta. È verissimo (e ancora una volta banale): si capisce, si entra
in un libro solo traducendolo, guardando dunque sotto i tappeti e fra le
pentole della cucina, pulite e sporche. Ho scoperto l’ossessione
assoluta di Tolstoj per i denti (li cita in ogni possibile occasione,
come motivo di vanto e come metafora rozza ma efficace del dolore,
arrivando a finire con Vronskij che parte per la Serbia tenendosi una
guancia) e per i treni (ma questa era vagamente più nota…), ho scoperto
la sua abilità assoluta di mettersi nei panni, nella mente e nella
lingua di diversi tipi di donna (senza scivolare quasi mai nella misoginia), ho riscoperto il suo sarcasmo velato ma sempre a bersaglio…
Insomma, se dovessi dire che cosa spero
di avere ottenuto con questa traduzione, è senz’altro di avere
restituito almeno un po’ di vita ai personaggi e alle vicende, facendo
sì che chi legge abbia una voglia incontenibile di girare le pagine come
era accaduto ai primi lettori di Tolstoj.
…Questo perché ho stampata in mente la
volta in cui, sull’aereo che mi portava a Madrid al matrimonio di due
amici carissimi, il passeggero accanto a me stava leggendo proprio Anna
Karenina. “Le piace?” gli chiesi. “Oh no, è una gran noia, e so anche
come va a finire!”.
Ecco, questo il lurido vecchio non se lo merita davvero.
P.S. Non capita spesso di poter
ringraziare chi ha messo una zampa in un lavoro importante. E allora
approfitto dell’occasione. Grazie per la scrupolosa, ma rispettosissima
rilettura a Enrico Ganni e Valentina Barbero (che hanno sopportato senza
evidente stupore anche le mie mail più sconclusionate e ansiogene). E
grazie alle mie due lettrici: Giulia Baselica e Letizia Kostner. Mille
pagine sono una prova d’amore, non d’amicizia.
***
giovedì 21 luglio 2016
Pace non cerco, guerra non sopporto
Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno
Pieno di canti soffocati. Agogno
La nebbia ed il silenzio in un gran porto.
Dino Campana
Pace non trovo, et non ò da far guerra;
e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;
et volo sopra ’l cielo, et giaccio in terra;
et nulla stringo, et tutto ’l mondo abbraccio.
Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra,
né per suo mi riten né scioglie il laccio;
et non m’ancide Amore, et non mi sferra,
né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio.
Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido;
et bramo di perir, et cheggio aita;
et ò in odio me stesso, et amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido;
egualmente mi spiace morte et vita:
in questo stato son, donna, per voi.
Francesco Petrarca
Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno
Pieno di canti soffocati. Agogno
La nebbia ed il silenzio in un gran porto.
Dino Campana
Pace non trovo, et non ò da far guerra;
e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;
et volo sopra ’l cielo, et giaccio in terra;
et nulla stringo, et tutto ’l mondo abbraccio.
Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra,
né per suo mi riten né scioglie il laccio;
et non m’ancide Amore, et non mi sferra,
né mi vuol vivo, né mi trae d’impaccio.
Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido;
et bramo di perir, et cheggio aita;
et ò in odio me stesso, et amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido;
egualmente mi spiace morte et vita:
in questo stato son, donna, per voi.
Francesco Petrarca
Ringraziamo Ettore per il dolce pensiero
..non fucilai gli sventurati in prigione...

"... non fucilai gli sventurati in prigione..."
Verso tratto dalla poesia di Esenin Non voglio ingannarti, 1923
Maria Luisa Meneghetti ??
Dal risvolto di copertina di "Storie al Muro, temi e personaggi della letteratura profana nell'arte medievale", Maria Luisa Meneghetti, Einaudi 2015 :
"La pluralità e la collisione dei significati emergono quali tratti caratteristici dei prodotti che fanno parte di questa "letteratura" e costituiscono probabilmente le ragioni più forti del fascino che essi ancora sanno esercitare".
In Libreria è scoppiato un vespaio. Come mai viene usato il termine "prodotti" ?
Non si tratta forse dello stesso osceno termine con cui indicano,ultimamente, i libri i vari e sostituibili curatori degli inserti letterari dei quotidiani?
Il libro è il libro, il libro si chiama libro.
Gentile Maria Luisa siamo quasi certi che quel termine non può averlo scelto lei.
mercoledì 20 luglio 2016
venerdì 15 luglio 2016
L'orrore di questo mondo ha tanti responsabili... Il potere e la ricerca di potere sono il Terrore
"Per il colonizzato, la vita non può nascere che dal cadavere in decomposizione del colono."
Frantz Fanon, I dannati della terra
Frantz Fanon, I dannati della terra
I tempi che stiamo vivendo, l'aria velenosa e il silenzio dell'arte e della scrittura
"Nelle miniere di carbone in America, i minatori portano spesso con se' un canarino. Lo mettono nel pozzo, e quello canta. E se per caso smette di cantare, per i minatori è il momento di uscire: l'aria è velenosa.
Pe me, noi scrittori siamo canarini."
Gore Vidal
Pe me, noi scrittori siamo canarini."
Gore Vidal
giovedì 14 luglio 2016
Manga do. Giorno 15. Chiba (Riportiamo il racconto dell'incontro tra Igort e Tsuge Tadao)

Al principio fu suo fatello maggiore, il celebre Yoshiharu, a spingerlo a raccontare con i disegni.
Per fargli capire i rudimenti del mestiere, gli fece riempire le campiture di nero, e poi lentamente fare
i puntini nelle sue tavole.
"Yoshiharu già pubblicava, aveva le idee chiare".
Poi anche lui intraprese la carriera di autore.
Tsuge Tadao è un uomo timido, dolce.
Oggi ha 75 anni e lo sguardo di un bambino sognatore.
Si schermisce quando gli dico che il suo lavoro, che è pubblicato ora in tutto il mondo, influenza il lavoro
di molto artisti, orientali e occidentali.
Lui, una delle figure chiave del movimento geki-ga (storie drammatche, in contrapposizione al termine man-ga,
storie di intrattenimento) raconta di un'infanzia senza sogni nell'immediato dopoguera.
"non pensavamo di diventare autori, non pensavano nulla, cercavamo di sopravvivere,
anche mangiare era un problema".
Quell'infanzia che sarebbe diventata un tormento, un'inferno, a distanza di tanti anni è ancora una ferita aperta.
"ho subito una violenza quotidiana, costante, non c'era giorno che non fossi pestato, ancora mi domando
il perché questo odio".
Preferisce non parlare della sua famiglia.
"Era una stuazione un po' particolare, preferico non ricordare", ma poi mostra il braccio sinistro, ha ancora le
cicatrici,"
"Ero il più piccolo".
Quando gli chiedo qualcosa delle sue prime storie lui dice che sì, erano cupe, ma né lui né il fratello
se ne rendevano conto. E non si rendevano conto di fare qualcosa di originale, loro raccontavano il mondo
che vedevano, quel mondo terribile che avevano conosciuto.
"Poi qualcuno ci fece notare che le nostre erano storie disperate, e Yoshiharu disse: va bene, allora facciamolo
diventare un marchio di fabbrica".

"Ci si trovava con mio fratello e con Tatsumi San, che era più grande di noi, e disegnava come noi storie di
crimini e di desolazione, ma non parlavamo mai di lavoro, tranne in rare occasioni.
Fu lui a inventae il termine Geki-ga."
Racconta di incontri per andare in giro a ridere e scherzare. Una stagione nella quale si produsseo storie
leggendarie, pubblicate su riviste che venivano date in affitto.
"c'era gente troppo povera per comprarle, allora le leggevano e le riportavano. Quando ricevetti la lettera
di Takano Shinzoo, che mi invitava a pubblicare su Garo cominciai a elaborare storie di uomini comuni
alle prese con una realtà durissima."
"Credevo che fosse fatta. E per 3 anni riuscii a vivere del mio lavoro di autore, avevo 27 anni."
“Poi nulla, con una moglie e un figlio, dovevo essere resposabile, cominciai a lavorare in una banca del sangue.
Quando potevo disegnavo le mie storie”.

“In casa i miei fratelli appena poterono se ne andarono a vivere per conto loro, io rimasi, anche allora ero
quello che lavorava, che manteneva la famiglia”.

"Adesso ho ripreso a disegnare a tempo pieno, vivo in un mondo che è per metà reale e metà il mio mondo”
Quando gli chiedo cosa ricorda della bomba atomica, dice che era un bambino e nessuno parlava di questa cosa, ma che è un dolore che è dentro ogni giapponese
“Mi domando perché lo fecero. Si disse che servì ad accellerare la fine della guerra, si può vedere anche
da quel punto di vista. Ma il Giappone era ormai in ginocchio si sapeva che era prossimo alla resa.
Qualcuno ha detto che l’America volesse fare vedere alla Russia, che all’epoca non aveva armi atomiche.
Fu un monito forse. E poi fu un test, volevano capire come funzionava”.
Sono momenti gravi, di silenzio.
“non servono le scuse dell’America, il Giappone ha fatto cose terribili in guerra. Con la Cina e con la Corea.
Le parole non servono a nulla”.
Si rimane attoniti, davanti ai silenzi di un grande uomo, di una persona semplice, che non ama viaggiare.
“L’Europa? Non sono andato neanche in Canada, non fa per me, non vado neppure a Tokyo”.
Quando parliamo delle figure misteriose di Yokai e Kappa che popolano la natura secondo la tradizione
giapponese, lui dice che gli interessa quella forza misteriosa, quella dimensione insondabile.
C’è una forza enorme in certe cose, in certe persone, mio fratello Yoshiharu, per esempio, la possiede”.
“Non so” dice sorridendo
“non so, a me piace vivere qui, in un piccolo villaggio”
Vive con le sue storie, che nascono da lampi, da momenti che si dilatano, e che non hanno smesso di
accompagnarlo per tutta la vita.
Come i ricordi di quella infanzia tormentata. Che lui interroga, con il sorriso malinconico di chi non capisce.

| fonte | ||||||||||
A R. J. Fischer
Da una lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti nel 2004:
Ma quello di Fischer non è un caso comune. Sono un vecchio amico di Bobby fin dal 1960, quando vincemmo ex aequo al torneo di Mar de La Plata. Bobby ha una personalità tormentata, me ne accorsi subito: è onesto e altruista, ma assolutamente asociale. Non si adegua al modo di vita di tutti, ha un elevatissimo senso della giustizia e non è disposto a compromessi né con sé stesso né con le persone circostanti. E' una persona che agisce quasi sempre a proprio svantaggio. Non voglio difendere o giustificare Bobby Fischer. Lui è fatto così. Vorrei chiederle soltanto una cosa: la grazia, la clemenza. Ma se per caso non è possibile, vorrei chiederle questo: la prego, corregga l'errore che ha commesso Francois Mitterrand nel 1992. Bobby ed io ci siamo macchiati dello stesso crimine. Applichi quindi le sanzioni anche contro di me: mi arresti, mi metta in cella con Bobby Fischer e ci faccia avere una scacchiera.
Questa lettera fu inviata dallo storico avversario di Fischer, Boris Spasskij, dopo che i due giocarono un match nel 1992 in Jugoslavia, allora sotto l'embargo statunitense. Circa vent'anni erano corsi dall'ultima apparizione pubblica di Fischer, vent'anni da quel Campionato Mondiale che un solitario di Brooklyn giunto dal nulla vinse con tutta la sua angosciante poesia. Poco dopo il match jugoslavo, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti emanò un mandato di arresto per Bobby, che passò gli ultimi anni della sua vita come rifugiato politico.
Ma quello di Fischer non è un caso comune. Sono un vecchio amico di Bobby fin dal 1960, quando vincemmo ex aequo al torneo di Mar de La Plata. Bobby ha una personalità tormentata, me ne accorsi subito: è onesto e altruista, ma assolutamente asociale. Non si adegua al modo di vita di tutti, ha un elevatissimo senso della giustizia e non è disposto a compromessi né con sé stesso né con le persone circostanti. E' una persona che agisce quasi sempre a proprio svantaggio. Non voglio difendere o giustificare Bobby Fischer. Lui è fatto così. Vorrei chiederle soltanto una cosa: la grazia, la clemenza. Ma se per caso non è possibile, vorrei chiederle questo: la prego, corregga l'errore che ha commesso Francois Mitterrand nel 1992. Bobby ed io ci siamo macchiati dello stesso crimine. Applichi quindi le sanzioni anche contro di me: mi arresti, mi metta in cella con Bobby Fischer e ci faccia avere una scacchiera.
Questa lettera fu inviata dallo storico avversario di Fischer, Boris Spasskij, dopo che i due giocarono un match nel 1992 in Jugoslavia, allora sotto l'embargo statunitense. Circa vent'anni erano corsi dall'ultima apparizione pubblica di Fischer, vent'anni da quel Campionato Mondiale che un solitario di Brooklyn giunto dal nulla vinse con tutta la sua angosciante poesia. Poco dopo il match jugoslavo, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti emanò un mandato di arresto per Bobby, che passò gli ultimi anni della sua vita come rifugiato politico.
Robert James Fischer (1943-2008)
mercoledì 13 luglio 2016
La Libreria di Vitte
Questa e' la libreria di Vitte nell'isola di Hiddensee, Germania.
L'isola si può percorrere solo a piedi, in bicicletta o altro mezzo elettrico.
E' uno dei tanti finis terrae che esistono al mondo, punto di arrivo e
di partenza, luogo in cui nascondersi o in cui trovare momenti di
calma.
Se ne parla anche qui http://www.delvecchioeditore.com/libro/cartaceo/203/kruso
L'isola si può percorrere solo a piedi, in bicicletta o altro mezzo elettrico.
E' uno dei tanti finis terrae che esistono al mondo, punto di arrivo e
di partenza, luogo in cui nascondersi o in cui trovare momenti di
calma.
Se ne parla anche qui http://www.delvecchioeditore.com/libro/cartaceo/203/kruso
Marco Lombardo Radice
 « In
queste istituzioni si tocca con mano l'esistenza di una microfisica del
potere e di una scala dell'oppressione in cui, ad esempio, l'infermiere
sfruttato e oppresso in un'ottica di classe può porsi, a sua volta,
come oppressore sull'anello più basso della catena: il paziente. »
« In
queste istituzioni si tocca con mano l'esistenza di una microfisica del
potere e di una scala dell'oppressione in cui, ad esempio, l'infermiere
sfruttato e oppresso in un'ottica di classe può porsi, a sua volta,
come oppressore sull'anello più basso della catena: il paziente. »
| (Marco Lombardo Radice, da Il raccoglitore nella segale) |
lunedì 11 luglio 2016
Contro l'uccisione di ragazzi afro da parte della polizia...
... e per Emmanuel ucciso dall'ignoranza omicida nazista a Fermo.
"Quando mi ribello lo schiavismo muore con me"
George Jackson, membro delle Pantere Nere ucciso nel carcere di San Quintino nel 1971 dagli aguzzini in divisa
"Quando mi ribello lo schiavismo muore con me"
George Jackson, membro delle Pantere Nere ucciso nel carcere di San Quintino nel 1971 dagli aguzzini in divisa
domenica 10 luglio 2016
WAO Festival 2016
All'interno del Parco dei Sette Frati, in prossimità della cima del Monte Peglia, Comune di San Venanzo, dal 4 al 7 Agosto, avverrà la seconda edizione del We Are One Festival.
Nelle giornate sarà possibile frequentare incontri in cui verranno discusse tecniche artistiche, modalità di architetture, abitudini alimentari, declinate all'interno di una filosofia che ha come fondamento la sperimentazione del riciclo, la cultura della sostenibilità, l'integrazione quindi con ciò che è circostante.
qui il sito del'evento
sabato 9 luglio 2016
Conversazioni con Burroughs
Questa è giusto l'ultima parte di una lunghissima trascrizione.
Il filo può essere riavvolto, ogni pagina indica dove sono terminate le precedenti.
Il filo può essere riavvolto, ogni pagina indica dove sono terminate le precedenti.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)