La montagna incantata a cui dà accesso un minoico labirinto
(Foto e testo di L.)
Gli atlanti sono aperti, spalancati, e i nomi delle città e dei deserti cantano
Edgar Morin
Giù lungo i gradini freddi e umidi poco assolati, nascono, tra profonde fessure grumose e grigie, fiori piccini di colore azzurro e rosa, con eroici pistilli che sembrano occhietti eccitati a cercare vita.
Un ciclo di appuntamenti per tornare a parlare di questione sociale e sindacato
Con chi se ne occupa ogni giorno
Le grandi mobilitazioni degli scorsi mesi hanno rimesso al centro l'azione del sindacato come motore di conflitto in questo Paese. Dalle piazze per la Palestina ai blocchi dell'Ilva di Genova, passando per la Prosus di Vescovato e le mobilitazioni contro la legge finanziaria, a determinare le mbilitazioni sono stati in larga misura, e con una centralità che non si vedeva da anni, le organizzazioni sindacali.
Gli interrogativi e le questioni irrisolte non mancano e noi abbiamo tante domanda da porre. Lo faremo con un ciclo di incontri che parli di lavoro con chi se ne occupa ogni giorno, dalla Cgil al sindacalismo di base, con compagni che abbiamo conosciuto nelle loro lotte o che non conosciamo ancora. Per essere chiari ecco una rapida carrellata degli interlocutori, in attesa del calendario ufficiale: Fiom, Usb, SI Cobas, Sudd Cobas, Multi.
Ci interessa tracciare un quadro di quello che si muove, dei ragionamenti e delle pratiche di lotta che esistono in Italia, senza aggirare i tanti ostacoli presenti ma senza nemmeno cedere a chiusure pregiudiziali e settarismi vari. Incontrandoci e confrontandoci possiamo cominciare ad affrontare davvero i problemi, ad andare a fondo delle cose.
Vi aspettiamo numerosi e curiose!
... mi risuonano sempre le parole di Ernesto De Martino, nel 1952, quando diceva che gli abitanti più poveri di Eboli volevano soprattutto una cosa, questa: che ”le loro storie personali cessino di consumarsi privatamente nel grande sfacelo”.
Vale sempre.
La
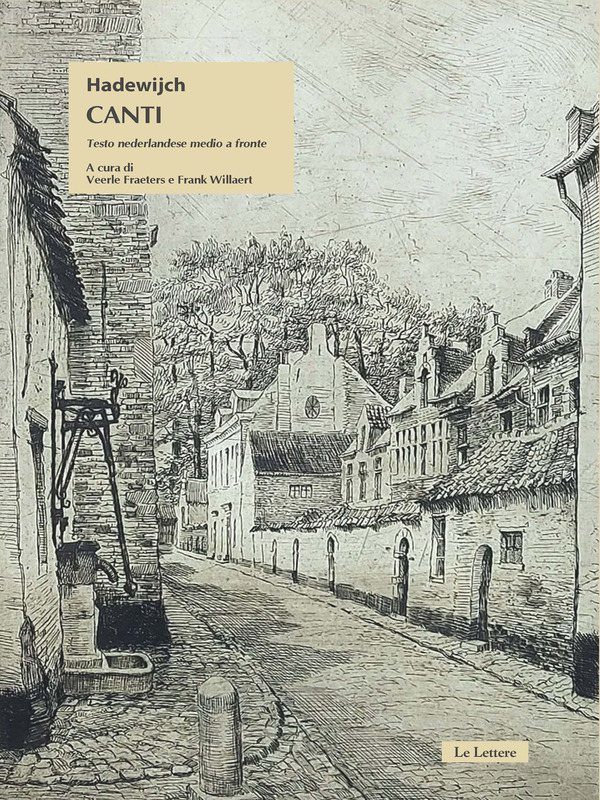
È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un buon patrimonio debba essere in cerca di moglie. Capolavoro senza tempo, Orgoglio e pregiudizio, pubblicato nel 1813, è il romanzo più luminoso e intenso di Jane Austen. Tra improvvisi malintesi, conversazioni brillanti, equivoci inaspettati e incontri risolutivi, si snoda una delle vicende d'amore più affascinanti della lettura mondiale: quella tra l'acuta e vivace Elizabeth Bennet e il misterioso e altero Mr Darcy.
io degraderei-a calci in culo- il medico
che dopo il bombardamento antibiotico
ha continuato a impipparmi,sfebbrato, di antibiotici per via orale
e come non bastasse mi ha iniettato l'"antinfluezale" nello stesso periodo
gli concederei di fare il barelliere
come il mio caro amico selinov
Il modo in cui ti voglio è oltre ogni idea di giusto e di sbagliato.
Là ove tutto s'incontra e tutto si fonde, ogni tempo e ogni luogo e ogni lingua, da tanto tu m'attendi, da tanto io t'attendo
Margherita Boninsegna ,1303
Johan Turi era un lappone con gli «occhi azzurri raggrinziti dal vento e dalle intemperie» che visse molti anni cacciando e guidando mandrie di renne, come tutta la sua gente. A lungo questo libro si elaborò nella sua mente, in silenzio. Pensava che tutto il male incombente sui lapponi, ormai trattati come «cani stranieri», fosse dovuto alla scarsa conoscenza della loro vita che avevano i popoli vicini. Così tentò di raccontare quella vita, con la massima precisione e sobrietà. Non sapeva che in quel momento stava offrendo risposte preziose a quesiti che sempre torniamo a porci: che cos’è un nomade? Che cos’è un cacciatore arcaico? Che cosa significa vivere in simbiosi con un animale (in questo caso la renna)? Attraverso le sue parole sentiamo risuonare una voce ammutolita

«nei tempi antichi ogni cosa sapeva parlare, tutti gli animali e gli alberi e le pietre e ogni cosa sulla terra, e così parleranno anche al momento del giudizio finale».
PER RISPONDERE A TUTTI COLORO CHE CHIEDONO PRECISIONE SUGLI ORARI ·
MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI, SABATO
h 9.30/12,30- 15,30/19,30
DOMENICA POMERIGGIO
h 15,30/ 19,00
LUNEDI CHIUSO
: «Come i lavoratori di Nottingham, anche noi amiamo le tecnologie che si integrano con la società, ma rifiutiamo quelle che distruggono il lavoro e i legami sociali». Il 18 novembre segnerà dunque l’avvio pubblico di una campagna che si annuncia diffusa e combattiva. Con un obiettivo chiaro: riportare il governo della scuola nelle mani di chi la vive ogni giorno e difendere la libertà di insegnamento dalle logiche del profitto e del controllo algoritmico.
Why do we keep mistaking efficiency for existence?
Il dominio non è esercitato da chi controlla, ma da chi accetta la logica del controllo come necessità ontologica.
È il punto in cui l’illusione diventa ambiente, e il potere si confonde con la struttura stessa della realtà percepita.
Il potere non è mai stato altro che una strategia di orientamento simbolico; la sua efficacia deriva dal consenso percettivo, non dalla forza.
Nessuna forma di dominio è reale se non come sogno condiviso.