Capracotta l’ho prima di tutto attraversata con le orecchie. È stato come assistere, di fronte a una scenografia quasi immobile, all’esecuzione di uno spartito per due voci, mescolate insieme nel primo pomeriggio estivo e silenzioso dell’Alto Molise. Questo paese situato a millequattrocento metri di altitudine al mio arrivo appare composto di strade deserte, colonizzate in egual misura da sole e vento. Mi suggerisce la vita che racchiude solo tramite suoni fuori campo, prodotti ai margini della mia vista e anche più lontano. Mentre cammino, infatti, si alternano all’udito isolate voci che, tra un uscio e una finestra, si domandano l’un l’altra se la corrente sia saltata anche lì. È in corso un black out, evidentemente giunto in contemporanea con me e il mulo, e ne vengo a conoscenza, da esterno, in questo modo, assorbendo la perplessità delle reazioni che filtra dall’interno delle case.
La sospensione del servizio elettrico, tuttavia, non turba minimamente lo zelo di una banda di ottoni, alimentata con la sola, testarda e primordiale forza di mani e polmoni, i cui echi mi raggiungono di tanto in tanto da chissà dove e fanno da contrappunto ai dialoghi di vicinato. Procedo ad addentrarmi in questo modo magico, con la scorta di questa colonna sonora a base di mormorante agitazione popolare, grancasse e tromboni, per quasi mezz’ora, accompagnato ora da una richiesta di informazioni, ora da un frammento di fanfara. Poco alla volta, comincio a incrociare persone che escono dalle abitazioni e si scambiano battute sull’inconveniente elettrico. Cantus firmus sembra essere la voce di una signora che, dalla porta di casa, intenta a prendersi cura di fiori in vaso, chiede a a chiunque passi se la corrente sia saltata anche in chiesa, per la quale evidentemente confida in poteri energetici soprannaturali. Lo chiede due, tre, quattro volte. E il bello è che ci abita davanti, alla chiesa, e potrebbe agevolmente controllare di persona.
Invece ci vado io. Raggiungo il sagrato, sopraelevato, e butto uno sguardo dal belvedere. Sulla montagna accanto un diligente parco eolico fa girare le sue pale per dispensare energia a qualcun altro, beffardo, lasciando a becco asciutto i capracottesi. Un manipolo dei quali, però, non fa una piega e continua a suonare. Sento che la banda prosegue, si ferma, riprende. Ancora non capisco dove si trovi, nel reticolo di stradine, né comprendo il perché di questo strano incedere fatto di partenze, fermate e ripartenze. Non sembra compatibile con un evento pubblico. È come il manifestarsi delle misteriose luci che Bilbo Baggins e i nani avvistano a più riprese nell’oscurità della selva di Bosco Atro. Ritorno verso una piazza lunga e stretta, credo il salotto del paese, dove ero passato prima trovandola del tutto spopolata. Come per magia, ora accoglie protagonisti e figuranti. Ai tavolini di un bar sul cui solenne ingresso campeggia la scritta Sci Club Capracotta, siede una rappresentanza di local, mentre cinquanta metri più in là, in un angolo e attiva a beneficio di nessuno, scorgo finalmente il gruppo musicale.
È proprio una banda: di pochi elementi ma efficiente, compatta, ben amalgamata. Tutti indossano la divisa, una sorta di mix stilistico tra polizia locale e capotreno, e sono allineati in formazione di fronte a una platea inesistente, proiettando i suoni dai padiglioni dei tromboni, del basso tuba, della tromba direttamente sul muro di fronte. Stanno provando, domani è domenica e sarà in programma qualcosa. Stanno facendo delle prove itineranti. Alcuni applausi da una panchina, a cui fanno eco altri dai tavoli del bar. Parte l’inno di Mameli che riscuote più successo del resto.
Scambio due battute con uno degli avventori, che mi spiega che quello è uno degli sci club più antichi d’Italia, fondato nel 1914. Chiedo se la neve c’è sempre, d’inverno. Risponde che, appena sopra, un duecento metri più in alto, a Prato Gentile, è garantita, mentre invece lì in paese non scende più come una volta. Osservo particolari architettonici in foggia tirolese e ripenso al vezzo di far apparire più alpine le località montane più alte dell’appennino, in una sorta di abdicazione identitaria. Arredi urbani composti da vecchi sci, ora adibiti a pezzi di panchine o di fioriere, appaiono incongrui, nel cuore dell’estate. Si va di fondo, da queste parti, e la parabola discendente del modello alpino, copiato altrove, non sembra aver preso l’abbrivio.
Mi affido io, invece, all’inerzia del viaggio. Distacco il mulo dalla stazione sciistica come si fa con quelle spaziali e riprendo a orbitare da solo. Lascio scorrere via Capracotta proseguendo la strada lungo un ideale anello panoramico che conduce verso Agnone, la luce del pomeriggio è fatta di quell’oro rosso che andava di moda negli anni Cinquanta e il paesaggio rivela una bellezza abituata ad essere consumata da pochi occhi per volta, che invecchia restando quasi ignota, come la bella del paese che non viene mai scoperta e portata via da un uomo di fuori. Capita. Capitava. Un po' nella vita reale, poi copiata dal cinema, e nei fotoromanzi, nelle leggende locali. Un impresario cinematografico, un industriale, un rappresentante, tutti scenari da innamoramento tipici di decenni ampiamente trascorsi. La fanciulla di qui non si perde in sogni su possibili Altrove. Particolari altoatesini a parte, si veste dei suoi panni e della sua propria bellezza, su alcune brochure si presenta seducente e si fa chiamare Molis’è, perché ride di chi dubita che, in effetti, “sia”, come si fa con le sirene, le banshee o altre creature mitologiche. Sa bene di esistere, si è mantenuta bene anche da sola e adesso è una rimarchevole cougar capace di attirare giovani in fuga dalle più fallimentari follie metropolitane, e anche meno giovani pionieri. Signora di un'isola a cui Odisseo approda richiamato dal suono dei tromboni di una banda ruffiana.































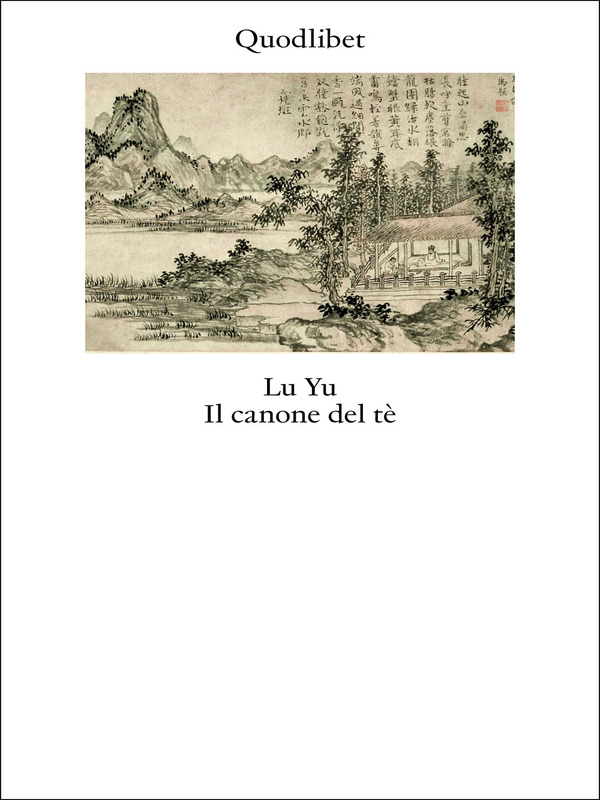
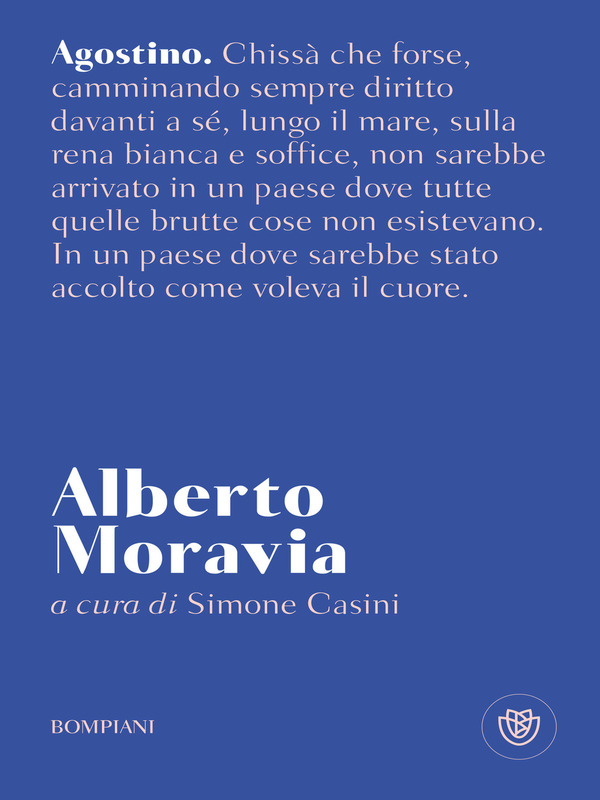


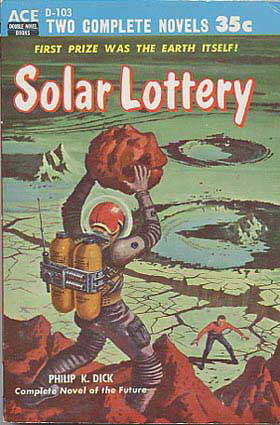


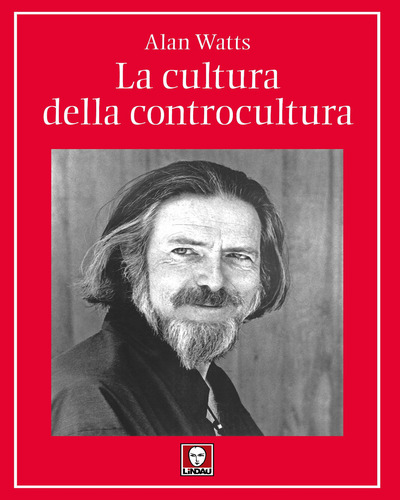 Questo libro colloca la controcultura americana (ed europea) in una
contesto culturale molto ampio, descrivendone i legami con tradizioni
filosofiche e spirituali, quali l'induismo, il taoismo, il buddismo e lo
sciamanesimo delle tribù asiatiche e americane. Il tema conduttore è
l'esperienza che l'uomo fa di se stesso e del mondo. Alla visione
egocentrica e miope della cultura dominante in occidente, Alan Watts
contrappone una visione globale e armonica del tutto e di noi stessi e
ci introduce a quelle «realtà» universali, transnazionali e
transculturali (quali, ad esempio, l'unità di tutto ciò che esiste, il
carattere armonico e spontaneo della natura ecc.) Che hanno informato di
sé la controcultura degli anni '60.
Questo libro colloca la controcultura americana (ed europea) in una
contesto culturale molto ampio, descrivendone i legami con tradizioni
filosofiche e spirituali, quali l'induismo, il taoismo, il buddismo e lo
sciamanesimo delle tribù asiatiche e americane. Il tema conduttore è
l'esperienza che l'uomo fa di se stesso e del mondo. Alla visione
egocentrica e miope della cultura dominante in occidente, Alan Watts
contrappone una visione globale e armonica del tutto e di noi stessi e
ci introduce a quelle «realtà» universali, transnazionali e
transculturali (quali, ad esempio, l'unità di tutto ciò che esiste, il
carattere armonico e spontaneo della natura ecc.) Che hanno informato di
sé la controcultura degli anni '60.


